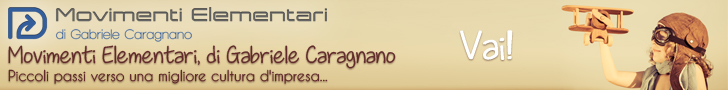Berta: «Perché le fabbriche tornano a essere il futuro dell’Italia»
Intervista a Beppe Berta di Diodato Pirone
Possibile che mentre ogni giorno si parla di imprese che chiudono, le fabbriche tornino a rappresentare il futuro dell’Italia? Il professor Giuseppe Berta, docente di storia dell’Industria alla Bocconi, assicura di sì. Una tesi decisamente controcorrente che il professore ha trasferito in un libro intitolato Produzione Intelligente, appena pubblicato per i tipi dell’Einaudi, dedicato ad un viaggio fra le fabbriche italiane. Ne esce un racconto molto ricco, profondamente diverso da quello trasferito ogni giorno dai mezzi d’informazione all’opinione pubblica italiana. Il racconto che fa capire meglio come mai, nonostante tutto, siamo la seconda potenza manifatturiera d’Europa. C’è poco da fare, il futuro italiano può ripartire proprio dall’Industria.
Iniziamo dalla fine del libro: lei scrive, senza retorica, che l’Italia delle fabbriche è l’Italia migliore. Quella che ci permette di sperare nel futuro. E perché allora non ne parla nessuno se non per dirne male?
«Potrei dire che da sempre considero l’Italia delle fabbriche uno dei volti migliori di questo Paese. Soprattutto perché gli italiani nei luoghi della produzione industriale hanno compiuto un loro percorso – faticoso e difficile – ma positivo verso una condizione civile. Imparando, anche attraverso il conflitto, il rispetto delle regole e il senso dei ruoli e della responsabilità. La fabbrica rappresenta uno spazio sociale e organizzativo concreto, dove si cerca una soluzione a problemi di funzionamento che possono essere risolti soltanto attraverso lo sviluppo di un’intelligenza comune delle questioni che vanno risolte. E’ soprattutto questo senso pratico e concreto che mi piace e che non si ritrova in tanti altri luoghi della nostra società, dove spesso il confronto diventa fine a se stesso. In fabbrica no, perché alla fine una soluzione occorre trovarla e i prodotti devono uscire. Purtroppo, l’Italia pubblica e ufficiale appare sempre più distratta; non sembra volersi misurare con queste dimensioni che invece sfidano la capacità delle persone e la loro attitudine a lavorare in gruppo».
Cos’è la fabbrica oggi?
«Noi non abbiamo un’immagine aggiornata della fabbrica. Quando mi capita di vedere delle immagini di produzione industriale alla televisione, vedo soprattutto immagini del passato, con linee di montaggio che risalgono a quaranta o a cinquant’anni fa. E invece oggi la fabbrica è un mix di tre componenti: tecnologia, organizzazione, capitale umano (nel senso di competenze e attitudini delle persone). Almeno è così nelle fabbriche più avanzate e moderne».
Ha girato per stabilimenti grandi e piccoli. Che “umore” ha trovato? Ha visto fatica? C’è speranza nelle fabbriche italiane?
«Nonostante tutto, a me pare che l’umore in fabbrica sia positivo. Perché, come accennavo prima, quando si va in fabbrica ci si va in genere con un’attitudine positiva e lì si prova il gusto di vedere ciò che si contribuisce a realizzare con la partecipazione collettiva delle persone. Certo, ci sono i problemi che presentano i luoghi di lavoro e quelli connessi alla retribuzione e così via, ma sempre più riscontro che le persone, magari per reazione all’ambiente esterno, ci stanno a farsi prendere dal gioco organizzativo della produzione».
Cosa sono oggi gli operai italiani?
«Gli operai italiani che ho incontrato sono lavoratori che ormai non si distinguono più dagli altri. Se si percorrono gli ambienti della produzione, si scopre che la vecchia distinzione fra “colletti blu” e “ colletti bianchi” appartiene al passato. Sul lavoro si è vestiti tutti allo stesso modo, ingegneri compresi. Questo è ovviamente finalizzato a imporre il valore del gioco di squadra. Ma attenzione fare squadra è molto più facile di una volta perché i processi lavorativi e ai lavoratori si richiede di metterci sempre più la testa, anche più delle mani. E i lavoratori sono molto più istruiti di un tempo. Anche sulle linee di montaggio hanno tutti un’istruzione secondaria. E ce n’è pure qualcuno con la laurea».
Perché l’Italia manifatturiera non fa racconto?
«Non fa racconto perché siamo stati educati negli stereotipi, che dipingevano delle fabbriche mostruosamente grandi. Che cos’è oggi una “grande” fabbrica? Pomigliano ha un po’ più di 2 mila addetti. La Pirelli di Settimo Torinese ne ha 1.250. La Maserati di Grugliasco ne ha intorno ai 2 mila. Sono ambienti trasformati, fabbriche bianche e luminose. Bisogna provare una autentica curiosità, non ideologica, per raccontare il nuovo volto di questa Italia industriale».
In tutto il mondo c’è un ritorno al manifatturiero. La Germania non soffre la crisi grazie alle sue industrie. Perché in Italia non c’è un sforzo collettivo a favore dell’industria?
«L’Italia non sa fare gioco di squadra. Altrimenti perché lasciamo che Pompei cada a pezzi e non sfruttiamo l’immenso potenziale turistico del nostro Paese, lasciando che si degradi? Noi non concepiamo le strutture della produzione come una sorta di bene da difendere collettivamente, nell’interesse della società e ci perdiamo nelle polemiche invece di guardare alla sostanza delle cose».
Può raccontare due o tre cose del tuo viaggio che ti hanno colpito di più?
«Episodi e soprattutto immagini ne avrei tante. Mi è rimasto impresso il ricordo dei lavoratori di Dalmine che regolano il processo dei laminatoi e seguono le fasi con la tipica cadenza dell’idioma bergamasco. Anche quelli di colore, perfettamente assimilati nella logica lavorativa».
Dopo Mirafiori, vede nuovi simboli del manifatturiero italiano?
“Non c’è più un simbolo dell’industrialismo capace di imporsi all’attenzione con la forza di Mirafiori. Che era poi la forza dei numeri: era una fabbrica grande come una città di provincia, con oltre 50 mila persone che stavano entro i suoi confini. Oggi alcuni vorrebbero elevare a simbolo della nuova produzione la stampante tridimensionale. Io ci andrei più cauto, non vorrei ridurre tutto alla tecnologia, pur determinante».
Consiglierebbe ad un giovane di entrare in fabbrica?
«Si può consigliare a un giovane il lavoro di fabbrica? Certo, se è un lavoro di qualità, che richiede impegno ma dà anche appagamento. Ci sono giovani che entrano nell’industria perché, al contrario di un tempo, essa fa viaggiare nel mondo i giovani quadri. Penso a quelli della torinese PrimaIndustrie che vanno in Cina, in Usa, in Finlandia. Che accompagnano le macchine laser che producono presso i clienti e ne assicurano il funzionamento. Su questa industria si può e si deve scommettere».